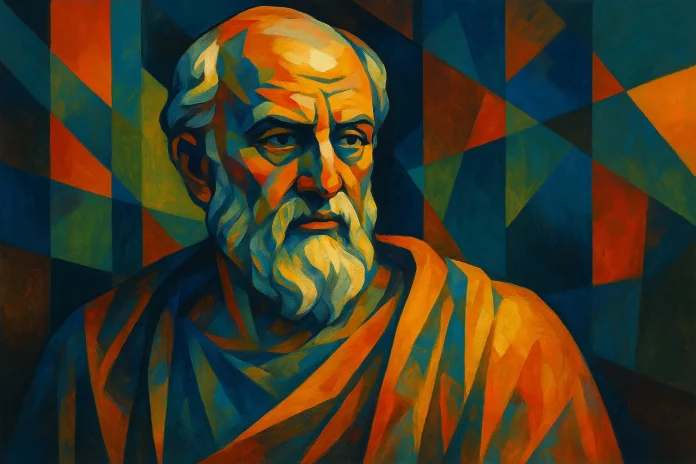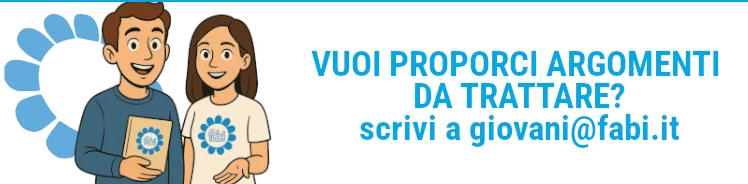In un’epoca nichilistica e caotica, in cui l’essere umano non si arrende al passar del tempo, ma si rassegna alla banalità del male c’è un uomo le cui parole, ancora oggi, allietano l’anima e infondono speranza.
Marco Tullio Cicerone e “L’Arte di Invecchiare”: Un’Eterna Lezione di Saggezza
«Senectus enim est natura loquacior» – «La vecchiaia è per sua natura più incline alla parola». Con questa ironica eppure dolcissima riflessione, Marco Tullio Cicerone ci introduce al suo De Senectute, uno dei testi più sublimi della latinità, un inno alla maturità dell’uomo, alla sua capacità di evolversi, alla dolcezza del tempo che scorre. È un’opera che, attraverso le parole di Catone il Censore, eleva la vecchiaia da triste decadimento a suprema stagione dell’intelletto, una fase della vita in cui il sapere si fa più profondo, la parola più misurata e l’animo più sereno.
Ma chi era Cicerone, se non l’incarnazione stessa della sapienza e dell’eloquenza? Oratore impareggiabile, avvocato sopraffino, uomo politico dalla fibra incorruttibile, il suo nome risplende nella storia come simbolo della veritas e della iustitia, pilastri della sua visione del mondo – ne sa qualcosa Catilina. La sua retorica, studiata ancora oggi nelle scuole di ogni grado, non era un mero esercizio stilistico, ma la manifestazione di un’intelligenza acuta, capace di piegare il linguaggio al pensiero, di forgiare argomenti con la precisione di un artigiano e la maestosità di un poeta.
Cicerone, l’Oratore che Sfidò il Tempo «Cedant arma togae, concedat laurea linguae» – «Le armi cedano il passo alla toga, la gloria militare si inchini all’eloquenza».
Così Cicerone esaltava la superiorità della parola sul ferro delle legioni, la potenza del logos sulla brutalità della guerra. Egli fu un maestro nel persuadere, nel guidare le menti, nel rendere l’oratoria non solo un’arte, ma una missione civile. Difese accusati ingiustamente con il vigore della verità, come nel celebre caso di Sesto Roscio Amerino. Con le sue Catilinarie smascherò le trame oscure che minacciavano la res publica.
Ma l’uomo che sapeva parlare meglio di chiunque altro seppe anche riflettere sul silenzio della vecchiaia. Nel De Senectute, scritto nel 44 a.C., l’anno stesso della sua tragica morte, egli si congeda dal mondo non con amarezza, ma con una saggezza serena e luminosa, offrendo a chiunque lo legga un prezioso antidoto al timore del tempo che passa.
La Vecchiaia come Sublime Compimento della Vita «Omnibus horis aliquid addiscere» – «Imparare qualcosa in ogni momento».
Così Cicerone descrive l’atteggiamento che dovrebbe accompagnare ogni uomo nella sua esistenza, e in particolare nella vecchiaia, che egli non considera un declino, bensì il compimento naturale di un’esistenza vissuta con virtù e intelletto.
Nel De Senectute, la voce di Catone il Censore si eleva contro i pregiudizi che vedono la vecchiaia come un tempo di inedia e sofferenza. L’autore smonta quattro accuse principali: la vecchiaia ci allontana dalla vita attiva, indebolisce il corpo, priva dei piaceri e avvicina alla morte. A tutte risponde con la sapienza dell’esperienza: l’età avanzata è il tempo della riflessione, della coltivazione dello spirito, della libertà dalla schiavitù delle passioni.
«Ut extrema aetas et inchoata, sic media omnis cultu rationis debet esse munita» – «Come la giovinezza e la vecchiaia, così tutta l’età di mezzo deve essere fortificata dalla guida della ragione».
Per Cicerone, la chiave della felicità nella vecchiaia è la preparazione: un uomo che ha vissuto rettamente, che ha nutrito il suo animo con la conoscenza e la virtù, non ha nulla da temere dal trascorrere degli anni. Al contrario, può goderne con il cuore leggero, come un contadino che, giunto l’autunno, raccoglie i frutti del suo lavoro.
L’Invecchiare come Arte, non come Peso «Nihil mali est in senectute, nisi quod deliratio fit, quae etiam iuvenum saepissime est» – «Nella vecchiaia non vi è alcun male, se non la follia, che tuttavia si trova assai spesso anche nei giovani».
Cicerone ribalta il paradigma comune: se la vecchiaia è talvolta accompagnata da debolezza e acciacchi, lo stesso si può dire di qualsiasi fase della vita. Ma essa ha un vantaggio ineguagliabile: la pienezza della consapevolezza. L’uomo anziano ha superato le tempeste dell’ambizione, ha visto il mondo con occhi disincantati, ha imparato a distinguere l’essenziale dal superfluo.
Per lui, la saggezza non è un orpello, ma un conforto. I piaceri materiali possono affievolirsi, ma quelli dell’anima crescono. Leggere, conversare, insegnare, contemplare la natura questi sono i veri doni della vecchiaia, non la forza fisica o la bellezza effimera.
Una Prospettiva Rinnovata sulla Vita «O vitae philosophia dux! O virtutis indagatrix expultrixque vitiorum!» – «O filosofia, guida della vita! O ricercatrice della virtù e distruttrice dei vizi!».
Attraverso la filosofia, Cicerone ci invita a guardare alla vecchiaia non con timore, ma con gioia. Egli ci sprona a vivere ogni stagione della vita con pienezza, senza rimpianti e senza paure, perché «senectus honesta est, si se ipsa defendit, si ius suum retinet, si nemini emancipata est, si usque ad ultimum spiritum dominatur sui» – «La vecchiaia è onorevole se si difende da sola, se mantiene i propri diritti, se non è sottomessa a nessuno, se fino all’ultimo respiro mantiene il controllo su se stessa».
Cicerone ci lascia dunque un’eredità impagabile: la consapevolezza che il tempo non è un nemico, ma un alleato; che la vita è un viaggio e la vecchiaia ne è la luminosa conclusione, il momento in cui possiamo finalmente contemplare la strada percorsa con gratitudine e dignità.
Così, rileggendo De Senectute, ci accorgiamo che la vecchiaia non è il tramonto della vita, ma il suo crepuscolo dorato, un tempo di saggezza, di bellezza interiore, di serena attesa. E con le sue parole incise nella mente e nel cuore, non possiamo che guardare al futuro con un sorriso lieve, certi che il meglio deve ancora venire.