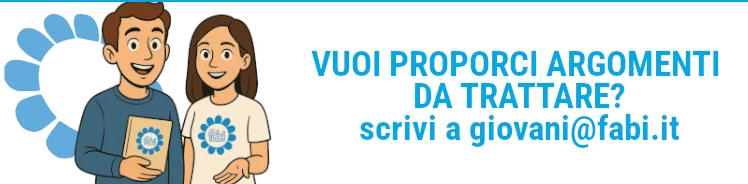L’attenzione per la prevenzione e la cura di malattie legate alla psiche, hanno determinato la nascita di nuove teorie psicologiche e psicoterapeutiche. Una tra queste è la drammaterapia, la quale riveste carattere di vera e propria disciplina psicoterapeutica, a differenza della teatroterapia, che non lo è.
Infatti, mentre la teatroterapia rappresenta una cura morale che, nel recitare un personaggio con passioni o idee fisse opposte a quella del malato, consentirebbe a quest’ultimo di liberarsene, nella drammaterapia, invece, l’eccitazione artistica delle emozioni come pietà, terrore, passione, etc, portate fino alle estreme conseguenze, purificherebbero l’anima degli spettatori dai loro conflitti interiori.
Già fin dall’antichità il filosofo Aristotele aveva intuito l’effetto peculiare che il dramma greco aveva sugli spettatori, liberandoli dalle contaminazioni e corruzioni della natura umana.
Assistere al dramma greco, diceva Aristotele, consentiva allo spettatore un maggiore coinvolgimento, ma anche una presa di distanza che gli offriva più consapevolezza e quindi una liberazione dalle passioni.
Le prime formulazioni di drammaterapia risalgono ai primi anni ‘60.
Tra i più importanti teorici di questa psicoterapia è il Dott. Robert Landy, direttore del dipartimento di Drammaterapia della New York University, il quale ha ripreso il concetto di distanza tra l’attore e il ruolo che interpreta.
Gli attori non si identificano con i personaggi che interpretano ma avvicinano le loro esperienze e se stessi alla performance, muovendosi da una realtà ordinaria a una realtà teatrale, ciò aiuta il paziente-attore a comprendere e alleviare i propri problemi psicologici e sociali, compresi malattie mentali e handicap.
Infatti, la Drammaterapia (“Dran” dal greco significa “compiere un’azione” ma con distacco) potenzia la creatività e l’abilità espressive del paziente il quale, proteso a esprimere le emozioni e la comunicazione verbale e fisica, entra in contatto con se stesso e quindi alla consapevolezza di sé.
Il modello terapeutico di Landy è il modello del ruolo il quale vede l’individuo quale rappresentante di numerosi ruoli, familiari e sociali nella vita reale. Questi ruoli vengono riproposti nella seduta della drammaterapia.
Secondo il Landy, durante la rappresentazione del dramma, l’attore entra ed esce in sequenza dal ruolo, mediante un continuo entrare e uscire da una realtà ad un’altra. Ed è proprio nello spazio intermedio che le potenzialità del paziente-attore possono emergere e consapevolizzarsi, attuando quel cambiamento che consente la ricostruzione della propria esperienza di vita.
La drammaterapia aiuta, quindi, ad armonizzare il rapporto corpo, voce, mente nella relazione con l’altro e allena alla spontaneità, alla improvvisazione che è un mezzo per facilitare lo sviluppo di un benessere psicofisico nel tempo.
L’improvvisazione e la simulazione esplorano i propri pensieri e le emozioni per cui certi blocchi psicologici derivanti da timidezze, paure, balbuzie possono sparire mediante l’espressione libera di sé in sede teatrale, come pure patologie derivanti da alcolismo, tossicodipendenza e altro.
Il filo che traccia la soglia tra scienza e arte è abbastanza sottile, se si considera l’idea che ciascun individuo è intrinsecamente “drammatico” nel suo sviluppo fin dalla più tenera età.
Costruire una realtà drammatica condivisa con altri in cui si avvicendano ruoli, situazioni, emozioni e complicità, dentro uno schema “finto”, incoraggia la creazione di un clima di solidarietà e fiducia nei rapporti interpersonali e sviluppa la sensibilità empatica del gruppo a vantaggio delle capacità relazionali.
Il “dramma”, dunque, quale strumento psicoterapeutico potente per
permettere agli individui di mettersi in gioco per trovare la soluzione ai propri problemi psicologici.
Ciò è molto utile nei rapporti lavorativi privati e pubblici, dove la coesione del gruppo richiede delle dinamiche relazionali di solidarietà e collaborazione necessari al buon funzionamento di qualsiasi azienda.