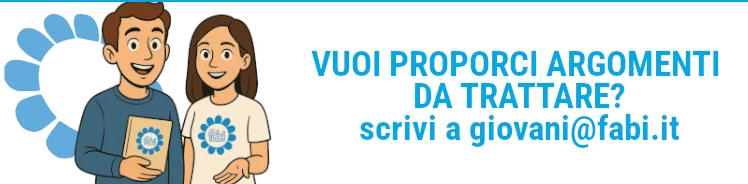Il 2020 è stato l’anno della comparsa di una pandemia virale che ha prodotto una crisi sanitaria senza precedenti in tutto il mondo. La pandemia da Covid-19, si è diffusa in maniera repentina in oltre 200 Paesi, producendo uno squilibrio socio-economico devastanti. Solo in Europa si contano circa 5 milioni di persone contagiate e 220 mila morti e nel resto del mondo circa 40 milioni di contagiati con oltre 2 milioni di morti, che via via aumentano, senza che si intravede, al momento, un trend di decrescita che faccia sperare in una fine dei contagi.
Questa pandemia può paragonarsi a una rivoluzione globale che sta coinvolgendo non solo l’aspetto sanitario ma anche quello economico delle nazioni, determinando una grave recessione, ritenuta da alcuni più austera della grande depressione del 1929, con un impatto devastante in termini occupazionali.
Il volto della pandemia ha allargato la forbice tra ricchi e poveri e ha sovvertito tutti gli schemi, le dinamiche e i progetti delle nostre società. Il mondo si è scoperto improvvisamente fragile e impreparato. Secondo i dati della Banca Mondiale, coloro che sono costretti a vivere con meno di due dollari al giorno sono saliti a più di 114 milioni.
In Italia i lavoratori precari, quelli saltuari, le partite iva, i piccoli imprenditori, i cassintegrati e i disoccupati all’improvviso si sono ritrovati privi di mezzi di sostentamento per garantire la sopravvivenza a se stessi e alla propria famiglia, con una ricaduta pesante anche per altre categorie come le badanti, colf in nero, camerieri, cuochi, commercianti, restauratori, artigiani.
Improvvisamente sono apparse sacche di povertà mai conosciute prima, che possiamo chiamare i “nuovissimi poveri in Italia”. La povertà impedisce di pagare l’affitto, il mutuo, di mantenere i figli a scuola fuori sede o assicurare loro i mezzi per la didattica a distanza. Crescono i senza tetto e le famiglie che dormono in macchina, specie al sud, mentre si raddoppia il numero delle famiglie che scendono nella povertà assoluta.
A queste si aggiungono i disagi delle persone sole e con disabili in casa o quelle che hanno dovuto rinunciare o rinviare le cure e l’assistenza sanitaria per il blocco dell’assistenza specialistica ordinaria e di prevenzione.
I bambini, più di tutti, stanno soffrendo gli effetti delle chiusure dovendo trascorrere le loro giornate sul balcone e nel cortile, mentre si registra in modo preoccupante la paura di molti adolescenti che si sono chiusi in casa.
Nel 2020 coloro che si sono rivolti per la prima volta alle Caritas diocesane o ad altre associazioni sono passati dal 31 al 45 per cento. Persone in numero consistente che bussano ai centri di accoglienza, alle parrocchie e ai patronati non si erano mai viste prima della pandemia.
Il fatto che il 30% degli italiani abbia chiesto il REM (Reddito di Emergenza), denota la necessità che il governo intervenga più incisivamente con il “Decreto Rilancio”, al fine di attenuare l’impatto della crisi attuale sulle fasce più vulnerabili, con particolare riferimento all’accesso agli ammortizzatori sociali.
L’unico modo per andare oltre l’emergenza è costruire una visione per il futuro del nostro paese anche se è difficile fare previsioni visto il perpetuarsi della pandemia con le sue varianti.
Si intravede, dunque, l’ipotesi di una nuova fase di “normalizzazione della povertà” che ha fatto emergere una spontanea e grandissima spinta alla solidarietà da parte di singoli e associazioni a sostegno delle famiglie. La catena di generosità che si è attivata è stata di gran lunga superiore alle aspettative, i cui operatori hanno reagito con più determinazione rispetto ai contraddittori interventi della politica.
Questo naturalmente non basta per ricostruire un futuro che guardi sia alla solidarietà sia alla dignità dei singoli e delle famiglie, dignità che si preserva solo con un servizio da restituire dagli stessi alla collettività mediante una prestazione lavorativa patrocinata dallo stato, enti pubblici o convenzionati.
L’educazione al servizio da parte dei beneficiari è espressione di partecipazione sociale e giustifica l’aiuto da parte dello Stato, di modo che ogni essere umano possa diventare artefice del proprio destino. In questo modo il principio di sussidiarietà e di servizio contraccambiato mostrano il loro valore.
Ed è proprio alla luce di tale assioma che occorre pensare a nuove ipotesi di lavoro con alternative a quelle “classiche”.
È un momento di responsabilità comune per chi dà e per chi riceve, anche perché le risorse necessarie a coprire un contraccolpo economico così inaspettato sono lungi da potere essere ripristinate.