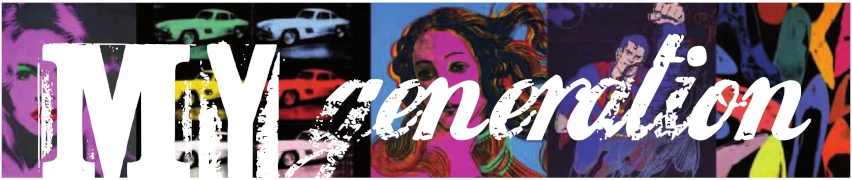“Ars est celare artem”, dicevano i latini. Ma oggi, nell’epoca dell’apparenza e del mercato, chi osa ancora celare l’arte nella vita?
In un’epoca storica in cui l’arte potrebbe rischiare di farsi orpello decorativo o feticcio da collezione, la voce di Philippe Daverio – storica, critica, dissacrante – continua a risuonare come quella di un cantore dissonante, affabile eppur implacabile, di un’estetica civile forse in dissoluzione. Daverio è stato molto più che un critico d’arte: è stato un umanista, un flâneur della conoscenza, un archeologo del presente armato non di pennello né di scalpello, ma di parola acuminata e ironica. Nato a Mulhouse, nell’Alsazia ambivalente fra Francia e Germania, il 17 ottobre 1949, è venuto a mancare nel 2020. Philippe Daverio incarnava un’eredità culturale europea che si è fatta sempre più rarefatta nei nostri tempi. Con la sua voce baritonale, lo sguardo mobile, il papillon da dandy ottocentesco, egli ha riportato il discorso sull’arte fuori dai consessi accademici e dalle logiche salottiere, riportandolo nel foro dell’opinione pubblica – dove, se l’arte ha ancora un senso, deve restare.
Il suo pensiero era tutt’altro che compiacente. Per lui l’arte non era un ambito chiuso, specialistico, né tanto meno un prodotto da confezionare per un pubblico inerte: era uno dei pochi strumenti rimasti per comprendere il mondo, o almeno le sue fratture più profonde. Il suo magistero televisivo – da Passepartout a Il Capitale – non era mai populista, bensì popolare nel senso più classico del termine: capace, cioè, di parlare a tutti senza rinunciare alla complessità.
Lo si potrebbe definire, con una certa dose di veracità, un conservatore illuminato. Un “reazionario del bello” che non si rifugiava nella nostalgia, bensì che interrogava il passato per spiegare il presente. La sua difesa del patrimonio artistico italiano era intrisa di una indignazione sorniona: contro la mediocrità dell’amministrazione pubblica, contro la pigrizia culturale della scuola, contro l’avanzata pervasiva del kitsch travestito da contemporaneità. Non mancava, nella sua analisi, una consapevolezza profonda della deriva che ha travolto l’arte nel Novecento. Ed è proprio in uno dei suoi scritti più penetranti – “Il secolo spezzato delle avanguardie. Il museo immaginato.” che tale intuizione si fa analisi lucidissima e visione filosofica.
Il secolo spezzato: un’epoca in frantumi
Il titolo stesso, “Il secolo spezzato”, evoca una frattura: non solo temporale, ma anche culturale, spirituale. Daverio legge il Novecento non come secolo della liberazione artistica, bensì come teatro di un trauma irrisolto. Le avanguardie, da Duchamp a Malevič, da Picasso a Fontana, lungi dall’essere esperimenti rivoluzionari del tutto riusciti, sono per Daverio l’evidenza di una perdita: la perdita di un centro, di un riferimento, di un orizzonte condiviso.
“L’arte non muore quando non è capita, ma quando smette di generare senso”, scriveva.
Il museo immaginato, allora, è una provocazione. Un museo che non esiste – e forse non può esistere – perché raccoglie i cocci di un’estetica esplosa. Un luogo ideale, mentale, in cui le opere dialogano non per affinità stilistica o cronologica, ma per affinità spirituale, per comunanza di frattura. In tal senso, Daverio non auspicava un ritorno al passato, ma un recupero della profondità. Il suo era un appello a rimettere l’arte al centro del pensiero, prima ancora che del mercato. La sua critica al contemporaneo non era frutto di rifiuto ideologico, ma di una delusione nutrita d’amore. Il sistema dell’arte, secondo lui, si era piegato alle leggi del consumo, del marketing, dell’epifania immediata. L’opera d’arte non era più opus, ma evento. Non più oggetto di contemplazione, ma strumento di transazione. Si è passati, diceva con sarcasmo, “dal marmo di Canova alla plastica di Koons, senza passare per la consapevolezza”.
L’arte come necessità
Daverio auspicava un’arte che tornasse ad essere “necessaria”. Non nel senso morale o didascalico, ma esistenziale. Un’arte che aiuti l’uomo moderno a sopravvivere alla desertificazione simbolica del mondo. In questo, si rifaceva più a Burri che a Warhol, più a Morandi che a Hirst. “Il silenzio di una bottiglia di Morandi parla più della condizione umana che mille provocazioni postmoderne”, amava ripetere. Citando Plinio il Vecchio, affermava: “Nulla dies sine linea” – nessun giorno senza una linea. Ogni giorno deve produrre arte, pensiero, bellezza. Non come ornamento, ma come disciplina dello spirito. Per Daverio, l’arte era l’unica grammatica possibile in un mondo che aveva disimparato a leggere la realtà.
Un’eredità da maneggiare con cura.
Oggi che Philippe Daverio non c’è più, resta da domandarsi cosa fare della sua eredità. Non possiamo certo imbalsamare la sua lezione in un busto da porre in qualche aula universitaria. Dobbiamo, piuttosto, lasciarci disturbare dalla sua visione. Riscoprire l’arte come ferita e come cura. Come perdita e come rivelazione. Riconoscere – anche nei fallimenti delle avanguardie, anche nel rumore dell’arte contemporanea – l’urgenza di un ritorno alla profondità. Daverio ci ha insegnato che l’arte è sempre più avanti della società, e che la società, se vuole salvarsi, deve affrettarsi a raggiungerla. Ma per farlo, occorre il coraggio della lentezza, della riflessione, della “inutile” bellezza. E allora, parafrasando Orazio: “Ut pictura poësis erit” – come la pittura, così la poesia. L’arte non è uno specchio del mondo, ma il suo controcanto. E solo chi sa ascoltarlo, è veramente moderno.
Ma chi oggi ha ancora orecchio per la dissonanza? Chi riesce a distinguere il frastuono del mercato dal sussurro di un’anfora antica, o la malinconia di una natura morta da una provocazione plastificata? Daverio, con la sua penna colta e la sua voce teatrale, ci ha lasciato un lascito non facile: quello di restare inquieti, di dubitare dell’apparenza, di scegliere il bello come atto civile.
Nella sua “estetica del dubbio”, egli ha reso l’arte non tanto un luogo da visitare, ma un modo di abitare il mondo. Con la sua scomparsa, non abbiamo perso un critico, ma un interlocutore necessario: uno di quei pochi che sapevano vedere nell’opera non solo la mano dell’artista, ma il cuore di un’epoca, le sue vertigini e le sue omissioni. Forse, in fondo, Daverio sapeva che l’arte non può salvare il mondo. Ma era altrettanto convinto che senza arte, il mondo non meriti di essere salvato.